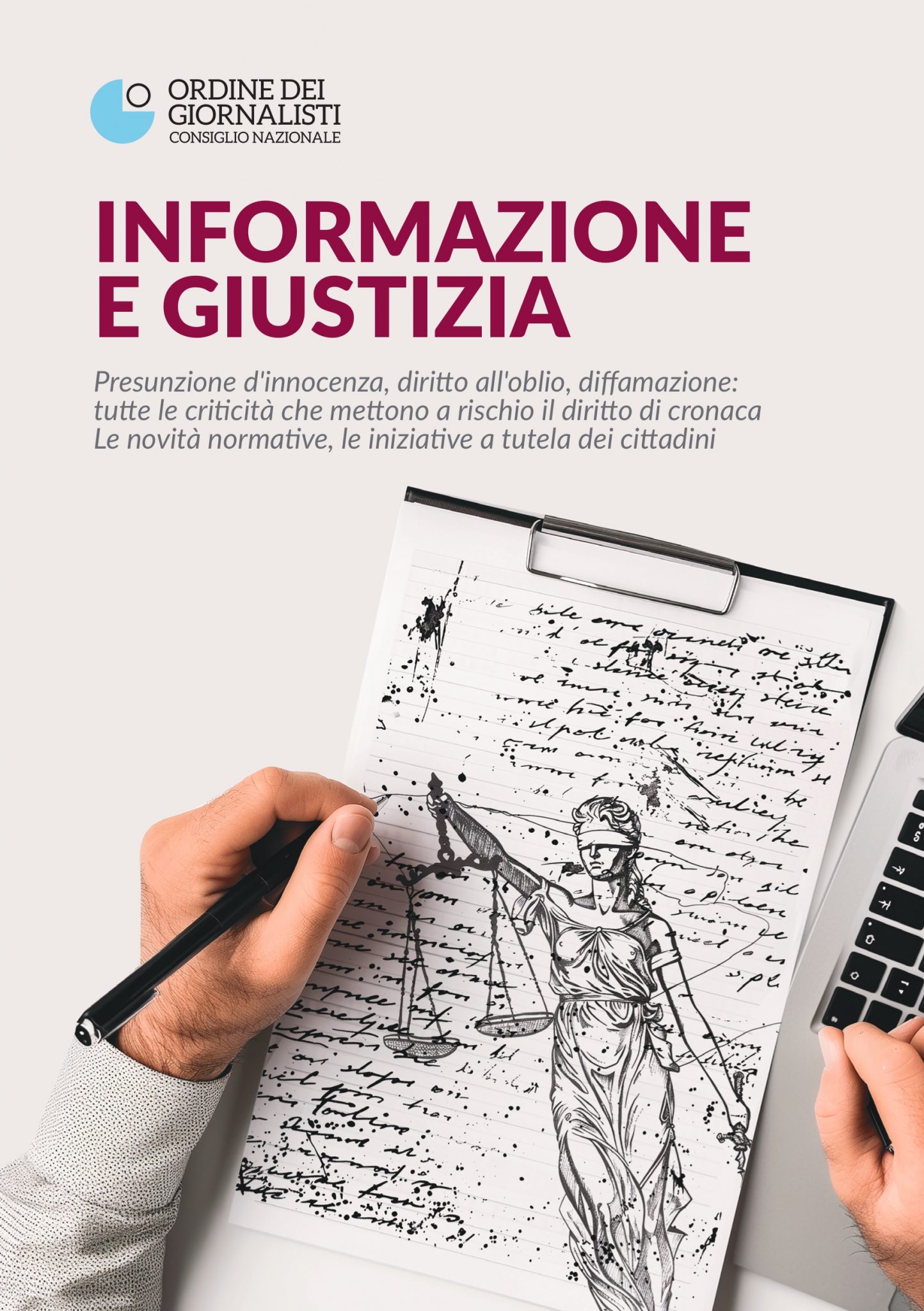La luce di Singal. Viaggio nel genocidio degli Yazidi di Sara Lucaroni. Postfazione di Riccardo Noury. People edizioni
Pubblichiamo l’introduzione al libro di Sara Lucaroni, autrice e giornalista e la postafazione di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.
La Telefonata (di Sara Lucaroni)
Ottobre 2014. A casa dei miei, nel piccolo studiolo, c’è una finestra che rimane sempre chiusa e su
cui a lungo ho tenuto attaccati fogliacci di appunti e la carta geografica dell’Iraq. Ho iniziato a interessarmene nel 1990, quando ho visto per la prima volta le immagini delle bombe in diretta tv:
Saddam Hussein aveva invaso il Kuwait e George H. W. Bush, a capo di una coalizione di 35 Paesi, era deciso a ristabilire la sovranità del piccolo emirato. All’inizio di quell’estate del 2014, invece, un nuovo gruppo terroristico, lo Stato Islamico – Daesh, secondo l’acronimo arabo – aveva proclamato addirittura un califfato. Aveva invaso pezzi di Siria e di Iraq, indottrinato e reclutato ragazzi, attirato avventurieri da tutto il mondo e messo in fuga mezzo milione di persone. Il 19 agosto aveva diffuso il video della decapitazione del fotoreporter americano James Foley. A settembre era toccato al giornalista Steven Sotloff, all’ex ingegnere della Royal Air Force David Cawthorne Haines e poi al cooperante britannico Alan Henning. L’organizzazione di lì a breve avrebbe rivendicato decine di attentati, dallo Yemen all’Afghanistan passando per l’Indonesia e l’Australia, e le stragi in Europa: Parigi, Bruxelles, Berlino, Nizza, Barcellona, Manchester, Londra.
Stava per piovere, quel giorno. Il computer era acceso in solitaria sulla piccola mensola che uso ancora oggi come scrivania e dove c’è spazio solo per una lampada da lettura. Il telefonino giaceva sul tappeto in mezzo alla stanza. Da inizio anno ero senza contratto – niente rinnovo – e ogni giorno leggevo cercando idee nuove, mandavo cv, consultavo annunci e vagliavo contatti per capire come ripartire. Avevo paura di non farcela. Ce l’ho anche oggi, quella paura. Suona il cellulare. Un numero che inizia col prefisso +964. Rispondo? No. Non voglio parlare con nessuno. Chi mi chiama dall’Iraq? Non conosco questo numero. Meglio evitare. Problema risolto.No, eccolo, ricomincia. Un’altra chiamata. Già tre squilli. Lascio libero l’istinto, prendo il telefono di scatto. «Pronto, chi è?» Fuori ora pioveva, ma le parole che arrivavano erano spezzate dal vento. Era il vento che quel giorno sferzava la montagna di Sinjar – Şingal, in curdo – sul confine siriano, nel nord del Kurdistan iracheno, assaltata dai miliziani dello Stato Islamico.
Centinaia di bambini fuggiti lassù da agosto avevano bisogno di vestiti più caldi e di cibo. E chi li difendeva, con mezzi del tutto inadatti, era protagonista di una piccola eroica resistenza. Ghazi Murad Barakat, un ragazzo della mia età tornato a casa dall’Europa, stava combattendo insieme alla sua famiglia e alla gente del suo villaggio, e questo chiedeva, dopo cinque ore di scalata sulle alture: «Fa freddo, mandateci le scarpe per i bambini». Questo libro racconta le conseguenze dell’aver risposto per caso a una telefonata che mi ha cambiato la vita. Otto mesi di chiamate dalla stessa montagna e parecchi articoli dopo, ho potuto organizzare il viaggio di cui leggerete in queste pagine. Il mio primo viaggio in Iraq, per parlare del genocidio della minoranza etnico- religiosa più misteriosa e discriminata della storia del Paese, finita anch’essa in quel pantano impastato dalle mani, dalle mire e dai molti errori dell’Occidente: gli yazidi. Adorano un angelo in forma di pavone, nessuno conosce i loro riti. Anzi, nessuno li conosceva prima che lo Stato Islamico li massacrasse. Sono partita come giornalista, senza esperienze di quel tipo sul campo e senza i mezzi che gli inviati di una testata hanno garantiti, ma soprattutto sono andata a Şingal come persona. Vediamola da vicino, la guerra. Iniziamo da questa. Additiamone, con tutte le forze che ho, l’immensa imbecillità, ho pensato. Sono arrivata il 20 luglio 2015 e ripartita il 10 agosto. Ho vissuto in una casa insieme a famiglie sfollate e coi soldati al fronte, mi sono finta una ragazza del posto, ho cercato di cancellare ogni forma anche involontaria di preconcetto, ho ascoltato con tutta me stessa. Ho avuto paura, ho pianto, mi sono arrabbiata. Ma non mi sono mai sentita così libera e perfettamente padrona della mia vita, capitana della mia volontà e della mia anima, come raccomanda la poesia di Henley. Questo perché ho capito che quel che succede a migliaia di
chilometri dal mio e dal nostro studiolo, o anche dall’altro capo del mondo, è affare di tutti. Non esistono luoghi lontani o gente sconosciuta: siamo tutti la stessa identica umanità. Dentro il mio lavoro, questa consapevolezza ha acceso una luce potentissima. Le pagine che leggerete sono scritte senza troppi artifici perché ho immaginato di portare con me, tenuto per mano o infilato nello zaino, chi con curiosità e benevolenza avrebbe deciso di sfogliarle. Questo è un viaggio che ho ancora addosso. E ogni incontro, pensiero, accadimento, intervista è reale. Per correttezza verso i lettori segnalo solo che il racconto è condensato nell’arco temporale di una settimana e che il capitolo dedicato al tempio di Laliş si riferisce a un viaggio successivo, così come l’incontro con Farida: non c’era stato modo nel 2015, ma quel che viene riportato sarebbe stato identico e dunque tutto è rigorosamente coerente col tempo in cui avvengono i fatti narrati. Lo troverete anche ingenuo, questo racconto. Sicuro. Non ho nascosto neanche certe figuracce. I grandi inviati forse le nascondono, a me non importa. Dovevo chiudere un cerchio, esattamente nel decennale della massima espansione dello Stato Islamico e del genocidio degli yazidi, gente generosa che mi ha accolta come una figlia, anche nell’emergenza più assoluta. Se non li conoscete ancora, li incontrerete dentro queste pagine. E vi piaceranno, ne sono certa. Ghazi aveva ricevuto il mio numero da un amico che non sapevamo di avere in comune, Ali al Jabiri, un grande artista nato a Baghdad e che non c’è più. Dopo di lui sono stati cruciali Fabio Carminati –responsabile della redazione esteri di Avvenire – e l’ex direttore Marco Tarquinio, che hanno sempre dato grande risalto alla causa di questa minoranza. Anche a quelle di tutti gli ultimi nel mondo. Sono tra i pochi che non smettono di seguire Paesi e storie perché nel frattempo ci sono bombe più fresche e più spettacolari altrove. L’ho sempre fatto anch’io, e in dieci anni non ho mai finito di scrivere di Şingal. Soprattutto di tornarci. «In questi ultimi anni sono scoppiate nuove guerre, come quella tra Ucraina e Russia, che è schifosa. Adesso c’è anche quella in Palestina, e spero per la pace in tutti e due i Paesi. Noi come iracheni le abbiamo viste le guerre, e come yazidi abbiamo visto bene quella che ha fatto il Daesh. Non avevamo mezzi, per noi è stato come difenderci lanciando un sasso nel mare. Ma abbiamo sempre praticato la pace. Non puoi pensare di sederti a mangiare con Dio se hai fatto male a qualcuno o addirittura hai ucciso. Che religione
hai? Vogliamo la pace per noi e anche nel resto del mondo» mi ha detto Ghazi alla fine di una lunga chiacchierata in cui gli avevo rivelato di aver scritto questo libro. Questo racconto è per lui e per gli yazidi, che mi hanno mostrato la praticità semplice della pace, dell’amicizia, della grazia. E dell’umanità, che vive e resiste alla stupidità della guerra. Anzi, che sfida a mani nude l’ignavia e l’indifferenza, il grande male di questa epoca.
La memoria e la giustizia (di Riccardo Noury)
Nell’anno in cui è stata pronunciata quella parola terribile, la più terribile di tutte – genocidio – in
riferimento ai crimini commessi da Israele contro la popolazione civile della Striscia di Gaza, nell’anno in cui commemoriamo quello avvenuto trent’anni fa in Ruanda, va ricordato quello subìto dalla popolazione yazida. Farlo ora è importante. Sono trascorsi dieci anni. «Il mondo intero sa cosa è capitato agli yazidi. Vorrei proprio sapere ora cosa intendono fare per noi…» Queste parole le disse, alcuni anni fa, a una ricercatrice di Amnesty International, una yazida di sessant’anni che viveva nel campo per sfollati interni di Chem Meshko. All’epoca aveva trentadue parenti ancora nelle mani del Daesh oppure scomparsi. Erano parole cariche di attesa. Il mondo sapeva e dunque, forse, avrebbe agito. Non so se il mondo abbia saputo. Una piccola parte di mondo, sì. Ma la memoria, salvo quella delle vittime delle violazioni di diritti umani, è breve. I mezzi d’informazione tradizionali si sono adeguati alla velocità di Internet e trattano le notizie come effimere tendenze del periodo. Un’emergenza supera un’altra. Allora, se una piccola parte di mondo ha saputo, poi ha anche dimenticato, e dunque ha inteso fare poco. Il mondo ha fatto poco per gli yazidi. Dal punto di vista della giustizia, quella per cui si combatte a volte per decenni sperando che arrivi prima della morte di chi è sopravvissuto, ricordo due sentenze emesse da
tribunali tedeschi in applicazione del principio della giurisdizione universale. Il 2 ottobre 2020, il tribunale di Amburgo ha condannato una donna di nazionalità tunisina, nota come Omaima A., a tre anni e mezzo di carcere per favoreggiamento nella commissione di crimini contro l’umanità ai danni delle yazide. Il 22 luglio 2021, la pena è stata aumentata di altri sei mesi perché la donna aveva anche costretto una delle sue “schiave” a fare le pulizie nel suo appartamento. Il 30 novembre 2021, l’Alta corte regionale di Francoforte ha condannato all’ergastolo un altro affiliato al Daesh, Taha al-Jumailly, per genocidio e crimini contro l’umanità. L’uomo è stato giudicato colpevole di avere, nel 2015, comprato, ridotto in schiavitù, torturato e fatto morire di sete Rania, una bambina yazida di cinque anni, lasciandola per ore sotto al sole con una temperatura di 50 gradi. Alla popolazione yazida, ai kuffar, infedeli, si è fatto di tutto. Ritrovo, nei rapporti di Amnesty International successivi al 2014, testimonianze estreme, agghiaccianti. «Durante la prigionia ci hanno umiliato: non ci davano da mangiare; picchiavano tutte, persino le bambine piccole; ci compravano e ci vendevano e ci facevano ogni cosa gli venisse in mente. Era come se non fossimo esseri umani. Io ora sono libera, ma altre si trovano ancora in questo inferno. Non abbiamo abbastanza denaro per sostenere noi stesse e riavere indietro le nostre parenti.» Questa è quella di “Nour”, sedici anni. Durante quasi due anni di prigionia nelle mani del Daesh, l’avevano trasferita sei volte in località diverse della Siria e dell’Iraq. Stuprata, aveva partorito una bimba. Ha riferito di essere stata stuprata da almeno dieci uomini che la “compravano” l’uno dall’altro. Nel dicembre 2015, la sua famiglia ha pagato un alto riscatto per riaverla libera. «A Mosul i combattenti dello Stato islamico obbligarono me e altre donne e ragazze a toglierci i vestiti e a metterci in posa per i fotografi prima di essere vendute. Ogni volta che provavo a scappare, mi legavano mani e piedi a un letto, mi stupravano in gruppo, mi frustavano coi cavi elettrici e mi lasciavano
senza cibo.» Sono le parole di “Jamila”, allora ventenne, che ha passato quasi un anno e mezzo comprata e venduta, sempre stuprata, scappata e ripresa, sempre punita, fino a quando, nel dicembre del 2015, è stata liberata a seguito del pagamento di un alto riscatto. “Jamila” ha pensato di suicidarsi. Come lei ci hanno pensato tante altre. E c’è chi non ce l’ha fatta a resistere a una maledetta altalena continua di rabbia e depressione. “Nermeen” si è tolta la vita a tredici anni, nascosta dentro a un prefabbricato del campo di Zakho. La sua sorella maggiore, “Seveh”, aveva provato a suicidarsi durante la prigionia in Siria ma era stata fermata in tempo dai suoi aguzzini, a cui serviva viva per le loro macabre fiere, compravendite e violenze di gruppo. Mi chiedo dove sia, in quale delle due parti del mondo yazida si trovi: se all’estero, cercando di ricostruire la propria esistenza, o nell’eterno precario presente dei campi. Malgrado lo straordinario sforzo di Yazda e di altre organizzazioni non governative, il sostegno alle donne e alle ragazze liberate, così come ai loro figli, è del tutto inadeguato. Gli yazidi, come emerge dall’intervista a Ghazala Jango della Youth Bridge Organization, sono esclusi dai luoghi dove si assumono decisioni, che sulla loro pelle vengono prese dalle più diverse autorità, senza coinvolgerli.Quanto all’enorme tema della riparazione, in Iraq è in vigore dal 2021 la Legge sui sopravvissuti yazidi. L’obiettivo della norma è nobile, ma la sua applicazione lo è molto meno. Nel testo originale si parlava di una «procedura amministrativa», un percorso che – nei programmi di assistenza alle persone sopravvissute a crimini internazionali – tende a facilitare l’accesso alla riparazione attraverso minori formalità, superando così gli ostacoli della re-vittimizzazione e della retraumatizzazione, nonché quello dell’esposizione allo stigma. Questi programmi si basano sulla “presunzione di buona fede” e su documentazione relativa a fatti accertati che non necessariamente riguardino la singola sopravvissuta. Tengono conto, inoltre, della difficoltà di reperire prove e testimoni di crimini di natura sessuale avvenuti in un conflitto. In altre parole, ricade sulle autorità l’onere di smentire, sulla base di prove credibili e circostanziate, le affermazioni della sopravvissuta. E invece, nel
2023, le autorità irachene hanno reso noto che, per accedere ai benefici della legge, sarà invece
necessario presentare una denuncia penale. Dovrà essere la sopravvissuta –attraverso testimonianze, referti, certificati medici e altro ancora– a dimostrare di aver subìto violenza sessuale. In questo modo, la riparazione e la giustizia resteranno un obiettivo lontano. L’assistenza umanitaria fornita da alcuni governi e dalle agenzie delle Nazioni Unite, come leggiamo nel capitolo 5, è insufficiente e di qualità variabile. Ha fatto eccezione, negli ultimi dieci anni, un programma finanziato con 95 milioni di euro dallo Stato del Baden- Württemberg, in Germania, grazie al quale, a genocidio ancora in corso, sono state trasportate mille sopravvissute yazide –compresa colei che sarebbe poi stata proclamata Nobel per la pace, Nadia Murad – per ricevere assistenza e terapie adeguate per due anni. Ma torniamo alla frase iniziale sul mondo che, avendo saputo, avrebbe dovuto fare qualcosa. Qualcosa per il popolo yazida lo ha fatto Sara Lucaroni: non solo nel 2024, ma nei dieci anni che hanno preceduto l’uscita di questo libro.
Dobbiamo principalmente a lei l’aver tenuto viva, in Italia, la memoria della feroce persecuzione. E
a chi, citato nell’introduzione, le ha prestato attenzione e le ha dato spazio per raccontare. Memoria, senza la quale non può esserci giustizia; ma anche ricordo, una parola il cui etimo evoca il cuore, l’emozione. Quella con cui ho accolto, poche settimane prima che questo libro andasse in stampa, la notizia della liberazione, da parte delle Forze democratiche siriane, di una donna yazida rimasta per dieci anni nelle mani del Daesh. Le forze curde l’hanno ritrovata nel campo di al-Hol, dove si trovano le “mogli del Daesh” e i loro figli. Costretta a essere moglie e a essere madre.
Come ha detto appena liberata: «Sono stata venduta e comprata come una pecora». Il lascito del genocidio degli yazidi è ancora in corso. Tante ragazze risultano ancora scomparse, le ferite della violenza sessuale sono aperte e per ricucirle, fisicamente e psicologicamente, forse non basterà una vita intera. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui questo libro va letto e fatto leggere.